QUANDO IL CUORE SI SPEGNE, LA CULLA SI SVUOTA La crisi della natalità tra economia, cultura e visione spirituale
Brahim Baya
Il 20 ottobre 2025 è stato pubblicato il rapporto ISTAT “Natalità e fecondità della popolazione residente” che certifica ancora una volta una drastica riduzione delle nascite in Italia. Per il 2024 il numero stimato di nuovi nati è di circa 370.000, con un tasso di fecondità medio di circa 1,18 figli per donna — il minimo storico. Nello stesso anno i decessi sono stati circa 650.000, generando un saldo naturale negativo di oltre 280.000 unità.
Negli stessi anni, nel resto dell’Europa e dell’Occidente, la fecondità complessiva resta al di sotto del livello di sostituzione generazionale (2,1 figli per donna). Nell’Unione Europea il tasso medio nel 2023 era di circa 1,38 figli per donna — segno di un declino generalizzato. Senza cambiamenti sostanziali o contributi migratori molto robusti, la popolazione invecchia, il numero di attivi si riduce, la pressione sui sistemi di pensione e sanità cresce — e ciò mette in discussione la tenuta economica e sociale dell’intero Occidente. Non si tratta più di un semplice trend demografico: è un vero e proprio “inverno demografico”, una trasformazione silenziosa e profonda.
TRA ECONOMIA, CULTURA E SOLITUDINE SOCIALE
Le cause individuate dagli esperti sono molteplici. Da un lato c’è il fattore economico: salari bassi, precarietà lavorativa, costo della casa e carenza di servizi per l’infanzia rendono difficile per molti giovani progettare una famiglia. Dall’altro, emerge un mutamento culturale: la famiglia è sempre meno percepita come un progetto collettivo e sempre più come un rischio individuale.
Molti sociologi parlano di un “nuovo individualismo” in cui la realizzazione personale prevale su ogni forma di responsabilità reciproca. La maternità e la paternità vengono rinviate all’infinito o evitate del tutto; il matrimonio stesso è sempre più raro, mentre la solitudine cresce come condizione sociale diffusa.
Ma se l’economia spiega come si arriva alla crisi, non spiega perché una società smetta di credere nella vita. È qui che la riflessione spirituale diventa indispensabile.
LA CHIAVE SPIRITUALE
Già decenni fa, l’Imam Abdessalam Yassine, un pensatore musulmano, analizzava nel suo libro “Islam e modernità” la radice profonda di queste crisi: non la povertà materiale, ma la povertà del senso.
Egli scrive:
«Perché la vita? Domanda centrale, domanda vitale. La nostra epoca tecnica e scientifica, che ha moltiplicato le conoscenze e le potenze dell’uomo, resta tuttavia tragicamente estranea a questa domanda.» (Islam e modernità, p. 115)
In questa domanda sospesa Yassine vede la ferita della modernità. L’uomo occidentale, dice, “ha smarrito la risposta perché ha smarrito il riferimento”, sostituendo alla fede la scienza, e alla verità il calcolo.
Il mondo moderno produce ricchezza, ma non significato; moltiplica mezzi, ma svuota fini. È ciò che Yassine chiama sterilità spirituale: un cuore che non sa più perché vivere, e dunque non sa più perché generare.
Quando l’uomo riduce l’esistenza alla sola dimensione biologica ed economica, il gesto del generare — che è un atto di fiducia e di continuità — perde il suo fondamento. La culla, simbolo della vita che continua, si svuota non per mancanza di soldi, ma per mancanza di senso.
LA RESPONSABILITÀ GENERATIVA
Ma se in Occidente la crisi è quella della sterilità spirituale, nel mondo musulmano — osserva Yassine — si manifesta spesso la crisi opposta: una prolificità senza educazione, una crescita quantitativa senza formazione qualitativa.
Il figlio, spiega, non è solo una creatura di Dio ma anche un’opera dell’essere umano, che ne porta la responsabilità. Se l’educazione è retta, la discendenza sarà benedetta; se viene trascurata, diventa ghuthā’, “schiuma del torrente”, come dice il Profeta ﷺ nel celebre hadith: “Sarete molti, ma come la schiuma della piena…” (Ahmad, Abu Dawud).
Yassine prosegue: «La civiltà che disprezza la famiglia e adora il profitto non può generare vita, ma solo solitudine. […] La forza di un popolo è nella sua madre educatrice, e la debolezza nella sua disgregazione familiare.» (Tanwīr al-Mu’mināt)
DUE CRISI, UN’UNICA RADICE
Il confronto tra Occidente e mondo musulmano rivela due sintomi diversi della stessa malattia:
– In Occidente, la sterilità nasce dal nichilismo e dalla perdita di senso.
– In molte società musulmane, la prolificità si accompagna a superficialità educativa e assenza di progetto.
Da un lato la culla è vuota, dall’altro è piena di “ghuthā’”. In entrambi i casi, ciò che manca è il cuore vivo, l’intenzionalità spirituale, la niyya della costruzione.
Yassine ci ricorda che la crisi della natalità — come quella della fede — è prima di tutto una crisi del cuore. Non si rimedia con bonus o politiche, ma con un rinnovamento del senso della vita e del dovere.
«La scienza trionfante […] ha sposato la filosofia positivistica materialista… e ha creduto di poter fare a meno della rivelazione, della profezia e della luce del cuore.» (Islam e modernità, p. 121)
VERSO UNA RINASCITA
Per Yassine, la via della rinascita passa attraverso la famiglia credente, luogo in cui la misericordia divina si fa educazione. Lì si costruisce l’umran, l’architettura morale e spirituale di una civiltà viva, fraterna e fiduciosa nel futuro.
Per questo scrive:
«L’Islam vuole un uomo completo e una donna completa, uniti da un matrimonio completo: religione, cuore, ragione e prole.» (Tanwīr al-Mu’mināt)
La culla si riempie quando il cuore si riaccende. Quando il figlio non è un costo, ma una baraka (una fonte di benedizione). Non si tratta di riprodurre un numero, ma di trasmettere un significato. La speranza demografica — e più ancora quella umana — nasce dalla fiducia in Dio, dalla responsabilità dell’educazione, dalla costruzione consapevole dell’avvenire.
CHI ERA L’IMAM ABDESSALAM YASSINEAbdessalam Yassine (1928–2012) è stato un pensatore, guida spirituale e riformatore islamico marocchino. Fondatore del movimento al-‘Adl wa-l-Ihsān (“Giustizia e Spiritualità”), ha dedicato la sua vita alla rinascita etica e spirituale dell’uomo e della società alla luce del Corano e della Sunna. I suoi oltre cinquanta testi spaziano dal pensiero politico alla spiritualità, dall’educazione alla storia, offrendo una visione integrale dell’Islam come via di giustizia, amore e costruzione civile (ʿUmran). Diverse sue opere sono state tradotte in lingua italiana e in diverse altre lingue mondiali e continuano a ispirare generazioni di credenti in tutto il mondo.
Le opinioni espresse in questo articolo non rappresentano necessariamente la posizione editoriale ufficiale di Italia Telegraph.






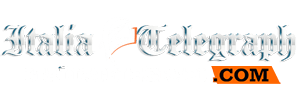

 English
English Español
Español Deutsch
Deutsch Français
Français العربية
العربية